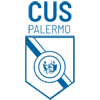Sedi
Palazzo Larderia
 Sito in C.so Vittorio Emanuele 188, con altro ingresso su via dei Cartari 19, è la sede amministrativa del Dipartimento.
Sito in C.so Vittorio Emanuele 188, con altro ingresso su via dei Cartari 19, è la sede amministrativa del Dipartimento.
E' stato sede del Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura e del Dipartimento Città e Territorio sino al 31 dicembre 2010.
Il 13 giugno 1567 il Senato di Palermo deliberava l’avvio di una grande operazione urbana: l’allargamento dell’antica strada del Cassaro e il suo prolungamento sino a piazza Marina. Si trattava di un intervento di grande respiro, destinato a modificare per sempre la forma della città e il suo destino. Imponenti palazzi della stessa altezza vennero progettati e allineati sui nuovi fronti della strada e grazie a incentivi e meccanismi legislativi innovativi il processo venne completato in tempi insolitamente brevi.
In un’area occupata da abitazioni modeste, probabilmente già colpite dall’alluvione del settembre 1558, il mercante savonese Paolo Ferreri iniziò la costruzione di una grande residenza. Benché soggetto nel corso degli ultimi secoli ad ampliamenti, mutazioni e rinnovamenti, è ancora possibile cogliere alcuni aspetti del primo progetto.
Dopo l’acquisto di immobili ricadenti nell’area, la costruzione è documentata a partire dal maggio 1571. I maestri coinvolti nella fabbrica sono in buona parte liguri e tra essi spicca il savonese Francesco Brilla; appare quindi molto plausibile che Ferreri desiderasse che la propria “domus magna” fosse ispirata alle più moderne residenze della sua patria. In particolare non si può escludere che ci fosse (non solo per Paolo Ferreri, ma anche per altri facoltosi committenti) il desiderio di emulare i risultati della prestigiosa Strada Nuova di Genova.
L’impianto planimetrico del palazzo, un volume cubico, con un atrio di ampio respiro, e, al piano superiore con un vasto salone centrale passante e aperto sul cortile attraverso una loggia a tre luci, immette delle sensibili novità nei modelli abitativi palermitani.
Come in altri esempi di via Toledo il piano terra era adibito a locali per botteghe e impaginato con un ordine bugnato. La realizzazione in pietra a vista di questa parte basamentale ancora visibile (estesa per nove campate) può rendere idea dell’impegno economico e della qualità di dettaglio richiesta nella fabbrica.
La storia successiva del palazzo non è ancora nota in molteplici aspetti.
Nel 1750 il celebre architetto Giovan Battista Vaccarini, su incarico del nuovo proprietario Antonio Ventimiglia, conte di Prades, elaborava una relazione sullo stato del palazzo. Lo scritto indica come i fronti laterali e posteriore fossero incompleti e che ancora quasi due secoli dopo l’avvio della fabbrica, la parte compiuta della costruzione era quella prospiciente il Cassaro. Vaccarini denuncia inoltre che i vani del piano nobile non erano tutti allo stesso livello, ma che la differenze di quote tra i solai erano risolte con fastidiose scale interne. La descrizione farebbe intuire che nel cantiere cinquecentesco erano state inglobate costruzioni preesistenti, unificate solo nel disegno di prospetto. Non sappiamo se la relazione dell’architetto comportò una immediata e generale riconfigurazione degli interni e l’avvio di fabbriche per sopraelevare i corpi intorno al cortile. Forse in questa fase si può pensare sia stata rimodernata la scala con l’introduzione del marmo rosso di Castellammare, un materiale alla moda dopo che nel 1735 era stato adottato nello scalone del palazzo Reale.
Una consistente serie di adeguamenti e trasformazioni vennero elaborati alla fine del XIX secolo. A questa fase si deve il completamento delle rifiniture della parte alta del prospetto, forse prima semplicemente intonacata e ritmata dalla sequenza di aperture e finestre. È probabile che anche l’atrio sia stato liberato da tramezzi e costruzioni che ne avevano modificato la spazialità.
L’ultima campagna di restauro risale al 1976 e all’82 per conto dell’I.N.A. Solo in tempi recenti la conoscenza della storia secolare del palazzo è emersa in buona parte grazie alle ricerche del professore Camillo Filangeri.
Edificio 8
 Sito in Viale delle Scienze, è stato sede del Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia e del Dipartimento di Rappresentazione sino al 31 dicembre 2010.
Sito in Viale delle Scienze, è stato sede del Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia e del Dipartimento di Rappresentazione sino al 31 dicembre 2010.
Inserito nel campus universitario del Parco d’Orleans, rientra tra gli edifici della Facoltà di Ingegneria, che vengono realizzati in fasi costruttive differenti. Tra il 1952 e il 1953 si avviano i lavori del primo stralcio del progetto, riguardante il corpo con gli Istituti (oggi Dipartimenti) di Topografia, Macchine, Idraulica. Successivamente, col secondo piano di ampliamento delle sedi universitarie (1960), vengono realizzati il corpo delle aule, quello per gli Istituti di Fisica Tecnica ed Elettrotecnica e, in ultimo, quello di Ingegneria Chimica e Nucleare. Negli anni settanta infine si costruisce la sede della Presidenza, progettata da Vittorio Ziino. Successivi interventi di manutenzione hanno riguardato l'edificio costituito dal blocco dei dipartimenti, con un sistema di volumi sporgenti che contiene le aule ad anfiteatro e dalla stecca per le aule. Sia il primo, con un impianto 'a pettine', dato dall'alternanza di pieni e vuoti, dove questi ultimi sono le corti interne, sia il secondo, con un semplice impianto lineare, si reggono su un sistema di portici. I prospetti sono caratterizzati dalla bicromia dell'intonaco; su un fondo bianco emergono, in grigio, le cornici delle finestre che evidenziano la maglia strutturale di travi e pilastri.
Ex monastero della Martorana
 Sito in Via Maqueda 175, è stato sede del Dipartimento di Design sino al 15 marzo 2010.
Sito in Via Maqueda 175, è stato sede del Dipartimento di Design sino al 15 marzo 2010.
Per decenni è stata la sede principale della facoltà. Proprio qui, nell’anno accademico 1866-67, cominciò a funzionare la Scuola di applicazione per gli ingegneri e architetti di Palermo, che vide nelle vesti di primo direttore Giovan Battista Filippo Basile.
La storia del monastero benedettino della Martorana è strettamente legata alle chiese normanne di San Cataldo e di Santa Maria dell’Ammiraglio, quest’ultima dal 1435 annessa al monastero e per questo oggi comunemente denominata “la Martorana”. Le monache avevano sulla chiesa un “belvedere” che sarebbe stato demolito nel 1874 e un altro - che permetteva loro di assistere alle processioni sul Cassaro - era sul Palazzo Bordonaro, anch’esso demolito alla fine dell’800. Ma c’era un importante legame anche con le vicende della sede comunale, visto che la chiesa si apriva sull’antico piano della Corte (l’attuale piazza Bellini), sul quale anche il monastero aveva accesso. Si trattava, quindi, di un luogo di grande importanza non solo religiosa ma anche politica.
Non esistono molte notizie sulle fasi di trasformazione di quest’antica costruzione, fondata nel 1194 da Goffredo ed Eloisa Martorana. Sicuramente una fase costruttiva importante è quella collegata all’apertura, nel 1600, della via Maqueda, la cui realizzazione determinò la demolizione di una buona fetta della costruzione e la sistemazione dell’ala che oggi prospetta su via Maqueda, fissandone la nuova facciata sul filo odierno, mentre a settentrione confinava con l’edificio voluto nel 1620 dal Senato, mentre era pretore Alvaro Ribadeneira, per l’Accademia d’armi dei cavalieri. Il progetto venne affidato all’architetto Mariano Smiriglio, che riutilizzò una rimessa dove il Senato custodiva le sue carrozze (“la cavallerizza del pretore”) e annesse un piccolo tratto dell’atrio antistante la chiesa di San Cataldo. Nel 1636 all’Accademia sarebbe subentrata la Corte Pretoriana che vi sarebbe rimasta fino al 1819, per poi ospitare la Commissione scientifico-protomedicale e l’Officina centrale della notturna illuminazione.