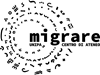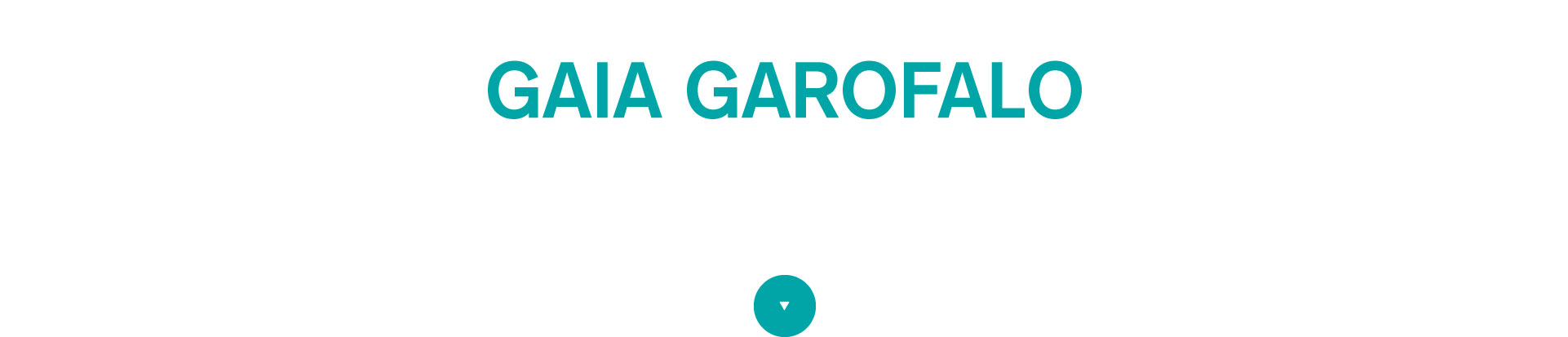
Molto spesso l’immagine canone della tossicodipendenza è costruita sul genere maschile perché altrettanto spesso protagonista e vittima di tale disturbo cronico. Ho deciso quindi di raccontare come accade l’approccio alle sostanze psicotrope, da un altro punto di vista di minoranza: le cause e le storie di una donna che entra nel tunnel della droga. Nel mio testo l’istituzione scolastica diventa protagonista di un nuovo inizio per una singola persona, ma soprattutto il gesto di narrazione è per la ragazza un momento di svolta, in cui riesce a parlare e a parlarsi, nonostante vada “fuori traccia”, sia nella vita che nel compito in classe.
FUORI TRACCIA
Era il silenzio e poi, un lampo.
Era un’altra vita, quella. Era correre sul bagnasciuga, mangiare la merendina schiacciata nella tasca dello zaino. Era prendere le mani dei miei e saltare come le corde di un’altalena.
Poi si diventa; non grandi, ma si diventa e basta.
Piangevo, ricordo. Piangevo mentre mamma provava a farmi le trecce, ma io non mi piacevo, io non mi guardavo, io me le strappavo. Mi nascondevo allacciandomi le scarpe, non tiravo più su i capelli.
Finì spenta sul mio letto a pregare di morire. Ero mai stata davvero credente? In quel momento forse era l’unico modo.
Dov’era tutto iniziato? Non lo so. Forse con mia mamma, mio papà, un’unica me ed un altro come me. No, non ricordo dove iniziò tutto, perché dell’infanzia ho solo il profumo delle lasagne della nonna e quella volta che l’ho vista su un letto d’ospedale e tutti credevano che non sapessi cosa stesse accadendo, eppure io l’avevo già vista la morte: nel nostro giardino, un gatto con gli occhi spalancati, le formiche nello stomaco. Mi misi a correre col cuore dentro la gola quel pomeriggio, non so dove, forse cercavo le braccia di nessuno. Non dissi nulla io.
Dicevo: non so da dove sia iniziato tutto. Ho pezzi sparsi in testa e forse anche sul pavimento.
Forse è stata la bottiglia di ghiaccio contro la guancia di mia mamma. Forse è stato riconoscere sapere cosa significhi “farsela sotto dalla paura” dentro le mura di casa. Forse è stata mia mamma col coltello che si tagliava le vene. Forse sono stata io. Forse è iniziato tutto quando sono iniziata io. Non ne sono certa.
Ricordo però quand’è che iniziò “la fuga”, come la chiamano gli altri. Per me invece fu “casa”, una vacanza. Era una bella canzone da ascoltare.
Avevo 15 anni ed ero bellissima, fresca, giocavo a “far finta di”, mi truccavo per sembrare grande per essere guardata da quelli di quinta. Uno di loro mi vide, mi guardò, sapeva che ero diversa da come mi mostrassi: “sei una bambina sei”, mi disse. Io non capivo come facessi ad illudere tutti tranne lui, e forse tra la folla cercavo questo, avere qualcuno che mi togliesse quella matita dagli occhi e che mi amasse quanto amavo io tutto quanto e anche che mi odiasse quanto io odiassi tutto quanto.
Mi scriveva poesie, canzoni, faceva tutte quelle cose che fanno i maschi quando hanno un unico obiettivo, arrivò a dirmi persino Ti amo e io ci credetti.
Lui e i suoi amici erano dei tipi a posto, era quello che dicevo ai miei, almeno, quelle rare volte in cui mi chiedevano dove stessi andando, cosa stessi facendo; mai capito se per un senso di protezione o di possessione.
Una sera andammo in un parco e quella per me fu la prima volta che andai in macchina con qualcuno che non fosse un parente.
C’era un’altra macchina, io ero seduta sulle gambe di lui ed altre ragazze, alcune più grandi di me e altre più piccole, facevano la stessa cosa con i loro fidanzati, solo che già loro si facevano mettere le mani ovunque, mentre io no, io avevo ancora paura, forse in quel contesto mi sentivo davvero quella bambina che ero. Lui mi aspettava e mi sembrava che fosse da venerare per fare questo sacrificio vitale.
Eravamo tutti insieme, era un campeggio, ma diversi da quelli che avevo vissuto solitamente. C’era però qualcuno che bruciava; in quel buio si riconoscevano delle piccole fiammelle e se ti fossi avvicinato, avresti potuto notare sopra un cucchiaino e poi acacnto un laccio al braccio. Mi sembrava che si facessero male ma anche bene.
A me però questo non piaceva. Ho sempre avuto paura degli aghi e sono sempre costretta a girarmi da un lato sennò svengo.
Lui allora mi guardò e mi disse che quella non era roba per me. Ci sedemmo sul prato insieme ad alcuni. Uno di questi si avvicinò con qualche banconota in mano e lui gli diede una bustina. Io chiesi come una scema “Cos’è?” e tutti scoppiarono a ridere, come se avessi chiesto se l’acqua bagna, se il sole asciuga, se il cielo è blu. Lui non rise, mi sorrise soltanto in una maniera molto tenera, pensavo. “Vuoi provare?”. Uno di quelli che lo aveva avvicinato con le banconote in mano disse a lui che ero troppo piccola e che certe responsabilità lui non se le voleva prendere. Io, un’altra volta come una scema risposi che non ero troppo piccola, che ero giusta, che non c’era bisogno di preoccuparsi. Allora lui mi spiegò come fare, come un padre che insegna alla figlia come si va in bicicletta senza rotelle e io ebbi fiducia in lui e in questo.
Mi sembrava un gioco, qualcosa di divertente; mi ricordava la polvere frizzante e fruttata che si metteva in bocca quando si era più piccoli.
Fu un attimo.
Era il silenzio e poi, un lampo.
Io e lui ci lasciammo e allora la coca divenne anche lui, una sostituzione che sapeva di me e lui e noi e di tutto quello che di bello non avrei mai avuto.
Smisi. Smisi perché come qualcuno mi fece iniziare, qualcuno mi fece smettere. Questa volta non fu alcun lui. Era una lei che insegnava nella mia scuola, che una delle poche volte in classe lasciò qualcosa da scrivere, non capii cosa esattamente, ma io scrissi tante cose, con la penna biascicante, con la gamba che tremava, con le labbra spaccate, con il freddo nelle mani scrissi.
Quando riconsegnò i compiti io non c’ero.
Venne a trovarmi lei a casa, con in mano il mio foglio di carta che teneva come si tiene un corpo morto, per dirmi che andai fuori traccia, ma che andava bene lo stesso.
Ed è stata la prima volta che mi andava bene qualcosa.
Il titolo “Loop infinito imperativo categorico” racchiude già quello che attraversano costantemente le persone affette da disturbi alimentari. Una costrizione cronica del loro essere, una disciplina contro la loro libertà di amare se stesse. È un mantra ripetitivo che però ha una conclusione nella perdita totale di tutto.

 Gaia Garofalo, classe ’97, nata e cresciuta a Palermo. Laureata alla triennale di Educazione di Comunità presso l’Università degli Studi di Palermo ed iscritta alla specialistica di Scienze pedagogiche indirizzo di pedagogia. Inoltre, aspirante giornalista pubblicista.
Gaia Garofalo, classe ’97, nata e cresciuta a Palermo. Laureata alla triennale di Educazione di Comunità presso l’Università degli Studi di Palermo ed iscritta alla specialistica di Scienze pedagogiche indirizzo di pedagogia. Inoltre, aspirante giornalista pubblicista.
GLI ALTRI VINCITORI